Dal 1790 ai giorni nostri, le storie parallele di due famiglie separate dal destino. Un naufragio e un delitto daranno vita a un cerchio che si chiuderà solo dopo tanti anni e molte vite.
Una linea sottile traccia il confine tra sogno e realtà, mentre un filo invisibile lega due terre: Carloforte e Pegli. Il Romanzo a puntate tratto dal libro “La forma della felicità” di Antonello Rivano
14.Il segreto di Luigi
Antonello Rivano
Carloforte 1970
I lavori a Villa Speranza sono quasi alla fine, una parte del vigneto è stata recuperata, anche gli ulivi sembrano voler riprendere vita. La casa è stata ampliata. Antonio e Giuseppe, malgrado quest’ultimo inizi a sentire il peso degli anni, hanno lavorato senza sosta. Manca ancora da allargare un pezzo di piazzale, quello che permetterà la costruzione di un pergolato di legno, un angolo fresco e riparato dove cenare fuori, nelle calde sere estive. La discussione fra padre e figlio è sulle misure del lavoro.
– Non se ne parla neppure, il fico non si tocca.
– Ma babbo, si tratta solo di pochi rami, ci fermiamo a ridosso del tronco. Non ho nessuna intenzione di toglierlo, so che è il simbolo stesso della proprietà. Mi hai raccontato mille volte la storia di Pietro, che avrebbe voluto finire i suoi giorni all’ombra dell’albero. So che è il posto dove la bisnonna Jolanda è morta. La storia della nostra famiglia la conosco benissimo, quest’albero ne fa parte.
– Quest’’albero non fa parte della storia della nostra famiglia, quest’albero fa parte della nostra famiglia.
-Benissimo, sono d’accordo con te, ma dobbiamo arrivare a ridosso del tronco con il terrapieno, lasceremo lo spazio di un paio di metri. Taglieremo solo le parti dei rami che eccederanno quella misura, e solo dalla parte della terrazza.
-Antonio, se lo fai seccare… te la vedi con me.
-Tengo a quella pianta quanto ci tieni tu, stai tranquillo, vivrà ancora tantissimi anni e mamma farà ancora marmellata e fichi secchi con i suoi frutti. Domani inizio a togliere le erbacce e gli arbusti che gli sono nati attorno, poi inizieremo gli scavi per le fondamenta del muro di contenimento.
***
Antonio deve approfittare del fatto che la barca sulla quale è imbarcato in questa stagione è stata portata al cantiere nautico per delle riparazioni. Non è facile trovare un altro periodo di bel tempo da dedicare completamente ai lavori della casa di campagna. Piccone alla mano sta ripulendo il terreno circostante al grande tronco del fico. Le forti braccia del giovane lavorano senza pausa, il rumore prodotto dall’attrezzo ha un ritmo regolare, costante.
A un tratto il suono cambia: non più metallo contro rami ma metallo contro roccia. <<Strano, qua dovrebbe essere tutta sabbia.>>. Appoggia il piccone e prende una roncola che ha portato con sé, di fronte a lui un arbusto poco più alto e folto degli altri. Bastano pochi tagli per rendesi conto che la pianta di macchia mediterranea è nata affiancata ad un piccolo ceppo di pietra, sul suo lato più largo una scritta: Ogni uomo dovrebbe avere un’isola cui tornare, un posto in cui sentirsi in pace con se stesso, dove riporre i suoi segreti e i suoi dolori, ricordare le gioie e dare un senso all‘ultimo suo viaggio.
***
-La pietra l’ha fatta mettere mio padre, è una frase di Pietro. La fece scolpire da Luigi. Non ho mai voluto ripulirla dalle sterpaglie. Quell’uomo mi ha fatto sempre una strana sensazione, ho imparato tanto da lui, non solo sull’agricoltura, era un uomo colto, molto sensibile. Doveva avere un qualcosa dentro che non lo faceva mai stare sereno del tutto, una specie d’inquietudine, un segreto che sembrava stesse sempre sul punto di svelare, ma era come se qualcosa più grande di lui glielo impedisse. Un dolore che spesso lo incupiva, e che poi, alla sua morte, ha in qualche modo pervaso tutta Villa Speranza, compreso mio padre.
Giuseppe è in piedi accanto alla piccola lapide. Quando il figlio gli ha detto di averla trovata è voluto andare a vederla. Un timore reverenziale gli aveva impedito di tenerla libera dalle erbacce, una paura che è giunto il momento di vincere, confortato anche dalla presenza di Antonio.
-Cosa vuoi fare? La lasciamo? Gli scavi non dovrebbero interessarla.
-No, toglila, mi ha sempre messo di malumore. Non voglio più niente che parli di dolori a Villa Speranza.
Antonio non se lo fa dire due volte, non piace neppure a lui quel legame con un passato che ha generato angosce e sventure. Del resto forse sarebbe anche ora di cambiare nome alla proprietà, il richiamo al nome di una barca affondata non ha portato molto bene. Ne parlerà a suo padre stasera, non sarà facile ma va fatto.
***
La pietra sembra andare più in profondità del previsto, occorre scavarle attorno per rimuoverla senza spezzarla, Antonio non vuole che ne rimanga un solo pezzetto sotto l’albero.
Ha quasi finito quando la pala incontra un ostacolo, ancora una volta non più sabbia, ora però il rumore è di metallo contro metallo. S’inginocchia e continua a scavare con le mani, per liberare alla terra l’oggetto che sta venendo alla luce, un cilindretto di ferro, racchiuso con un tappo di sughero. Curiosità, sorpresa, anche un po’ di preoccupazione; tutte sensazioni che si concentrano nell’attimo, l’istante in cui il passato incontra il presente. Tolto il tappo, sigillato con un po’ di ceralacca, Antonio estrae dall’interno un rotolo di carta ingiallito dal tempo. La scrittura è curata e precisa, per lui è facile leggere il suo contenuto:
Carloforte 15 aprile 1900.
Non so se questo piccolo custode del mio segreto sarà mai dissepolto, o se rimarrà nel grembo della terra che io ho amato. Ho deciso di scrivere su questo foglio una storia, la storia di un amore, anzi di due amori. Due amori che non potevano coesistere, per questo ho dovuto rinunciare ad entrambi.
Sono nato in un piccolo paese del basso Piemonte, mio padre era un proprietario terriero, avevamo un grande vigneto e producevamo un vino di alta qualità.
La mia era la vita di un ragazzo nato in una famiglia agiata, amavo quelle colline ricoperte di filari infiniti di viti, studiavo e passavo tantissimo tempo assieme ai contadini di mio padre, da loro ho imparato tutto quello che so di agricoltura. Avevo diciassette anni quando sentii un richiamo più forte di quelli del podere di famiglia, era la voce di Dio. Entrai in seminario che ero un ragazzo e ne uscii uomo e sacerdote. Fui prima destinato a una parrocchia di Torino, dopo alcuni anni divenni cappellano dei carabinieri del capoluogo piemontese.
Quasi subito capii che qualcosa in me stava cambiando, sensazioni che cercavo di reprimere, lunghe ore passate in preghiera per sconfiggere il demone che stava tentando la mia anima. Poi arrivò un giovane allievo ufficiale. Era brillante e intelligente, bello come un angelo. Fu subito amicizia, parlavamo di filosofia e di arte, le nostre conversazioni duravano ore. Quando era in libera uscita spesso andavamo a berci un bicchiere di buon vino. Più il tempo passava e più mi affezionavo a quel ragazzo, poi l’affetto si tramutò in qualcos’altro: mi stavo innamorando di lui. Sinora avevo amato solo i miei genitori e Dio, ma questo era un amore diverso, un amore che si stava trasformando in desiderio dell’altro. Un sentimento che normalmente rendeva felici a me terrorizzava. Che cosa fare? Che posto aveva quell’uomo nella mia vita dedicata a Dio? Parlai con il mio confessore, mi aspettavo una reazione violenta, una condanna assoluta o la compassione cristiana, invece la cosa parve non sorprenderlo. Come se quello che io vivevo come un dramma fosse normale per la chiesa, si comportò più da complice che da confessore. Mi fece capire che la cosa importante era che tutto rimanesse nel segreto, che nulla trapelasse al di fuori del grembo ecclesiastico. Uscii disgustato da quel colloquio, mi sentivo sporco; la purezza del mio amore, la sincerità del mio turbamento, ridotta a torbida perversione. Speravo in cuor mio che quella non fosse la posizione della chiesa ma solo quella di un suo elemento. Continuai a frequentare quel giovane, non potevo rinunciare alla sua compagnia, mi accontentavo di averlo come amico. Poi accadde ciò che fece precipitare le cose: eravamo in carrozza, stavamo andando a passare un pomeriggio in campagna a casa dei suoi, nobili di Como. Ad un tratto, vuoi per la strada o l’imperizia del cocchiere, la carrozza ebbe un sussulto; mi ritrovai addosso a lui. Nonostante la situazione si fosse ristabilita indugiai più del dovuto fra le sue braccia, e il mio volto fu pericolosamente vicino al suo. Notai l’imbarazzo del giovane, che mi allontanò con modi bruschi, come se all’improvviso si fosse reso conto di essere in compagnia di un appestato. Fece girare la carrozza e facemmo rientro in caserma. Si allontanò senza rivolgermi la parola. Il giorno dopo ricevetti l’ordine di comparizione del mio vescovo. Senza fare accenno ai motivi del provvedimento mi disse che ero stato trasferito in un piccolo paese di montagna. In pratica si trattava di un vero e proprio esilio: il paese, posto ai limiti di una strada impraticabile per buona parte dell’anno, non contava che 800 anime. Mi stavo convincendo che la mia era una deviazione, molto peggio che una malattia, mi sentivo per la prima volta abbandonato da Dio. Furono mesi di quasi completa solitudine, i paesani erano coscienti del fatto che ero stato mandato lì per punizione, avevano sinora avuto solo prelati anziani e al termine della loro vita ecclesiastica. Nel dubbio su quale fosse la mia colpa mi evitavano, limitandosi a farsi vedere solo a poche funzioni e a cercarmi per funerali, battesimi e matrimoni. Ebbi cosi molto tempo per riflettere sulla mia vita e sulla mia vocazione. Se da una parte sentivo di appartenere completamente a Dio, dall’altra ne sentivo la distanza, abbandonato a me stesso. Alla fine di un interminabile inverno presi la decisione di abbandonare l’abito talare, anche se dentro mi sono sempre sentito ancora prete e servitore di Dio.
Per anni ho vagato in cerca di un po’ di pace, facendo il mestiere che meglio conoscevo: il contadino. Il lascito di mio padre l’ho diviso fra tutti quelli che lavoravano per noi. Non mi sono mai fermato a lungo in nessun posto, non mi sono mai più innamorato, né di uomo né di donna. In nessun luogo ho trovato la pace che cercavo, sinché un giorno non ho sentito parlare di quest’isola. Qua ho ritrovato Dio, nel mare azzurro e nel verde della sua campagna, nella quiete della sua selvaggia bellezza, nei suoi silenzi. Nella forza e capacità di sacrificio della sua gente. Qua sono ritornato ad amare il mio creatore. In Carlo ho trovato l’amico e il fratello, non è mai stato un padrone, mi ha dimostrato affetto e una riconoscenza infinita. Spesso mi ha confessato i timori verso sua moglie, donna arida e autoritaria. Se ancora avessi potuto provare amore per qualcuno sarebbe stato verso quell’uomo. In questo paradiso ho finalmente potuto riporre il mio dolore, cosi come ho riposto il mio segreto sotto quest’albero antico.
Gli Antinori sono stati la mia famiglia, che Dio li benedica assieme alla loro terra.
Tu che leggi prega per me.
Don Luigi Dionigi- Servo di Dio.
Antonio è combattuto tra il tenere per sé la sua scoperta o condividerla con i genitori, il dubbio di un attimo. Si avvicina a un mucchietto di erba secca e vi ripone sopra il foglio, un fiammifero pone fine al segreto di Luigi.
–Luigi, non è che la tua benedizione abbia dato buoni frutti. Penso che questa terra abbia sofferto per la tua morte, cosi come mio nonno. In quanto al pregare, non ne sono mai stato capace. Non posso giudicarti come prete, non voglio giudicarti come uomo, in fondo la tua sola colpa è stata quella di amare…riposa in pace.
Continua…]
La prossima settima: Capitolo 15.Antica Osteria
I testi tratti dal romanzo di Antonello Rivano “La forma della felicità” (ilmiolibro.it, 2018) pubblicati sul Ponentino possono non corrispondere totalmente con quelli del libro e sono frutto di una rielaborazione dello stesso autore.
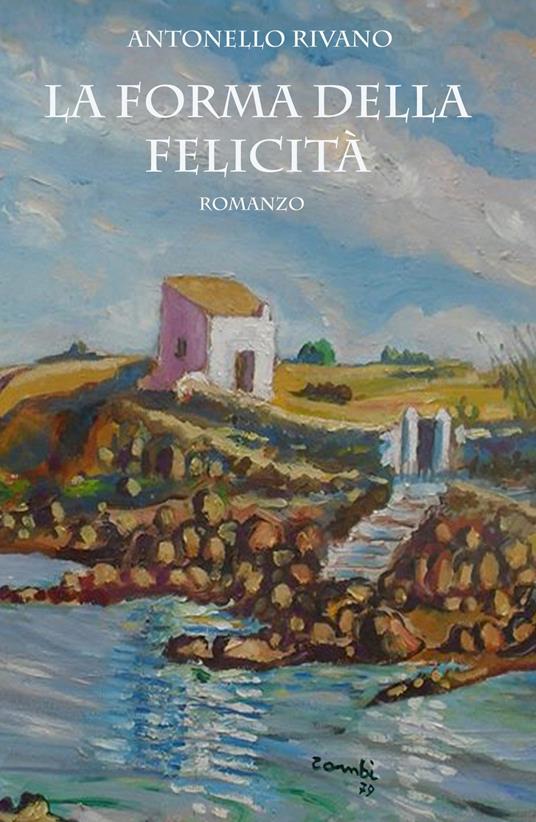
Il libro si può ordinare online su ilmiolibro , su Amazon, sui maggiori bookshop online o prenotarlo nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia.
La copertina originale dell’opera è del pittore carlofortino Salvatore Rombi
 Antonello Rivano
Antonello Rivano
Redattore Capo ilponentino.it
Capitoli già pubblicati:


